 |
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sui compensi per il trattamento economico accessorio erogati al personale non dirigenziale delle PA
La manovra 2026 ha previsto per il corrente anno che i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, sono assoggettati, salvo rinuncia espressa del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 4/E del 29 gennaio 2026, ha istituito una serie di codici tributo che sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘Importi a debito versati’.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello ‘F24 enti pubblici’ (F24 EP), dell’imposta sostitutiva in argomento, l’Agenzia ha istituito i seguenti codici tributo: ‘179E’, ‘180E’ e ‘181E’. I suddetti codici tributo sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’.
(Vedi risoluzione n. 4 del 2026)
|
 |
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato
La legge di Bilancio 2026 ha previsto che gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno in corso, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1°gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salvo rinuncia espressa del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.
L’imposta in parola si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33 mila euro.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite il modello F24, della citata imposta sostitutiva l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026, ha istituito una serie di codici tributo esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘Importi a debito versati’.
(Vedi risoluzione n. 3 del 2026)
|
 |
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, nonché per indennità di turno
La legge di Bilancio 2026 ha previsto, per l’anno in corso, che le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e nei giorni di riposo settimanale, nonché di indennità di turno e ulteriori emolumenti riconosciuti al lavoro a turno, siano assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite il modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 2/E del 29 gennaio 2026, ha istituito una serie di codici tributo che sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘Importi a debito versati’.
(Vedi risoluzione n. 2 del 2026)
|
 |
Credito d’imposta per gli investimenti di cui all’art. 38 Dl n. 19/2024 - Piano Transizione 5.0
Con il decreto legge n. 19/2025 è stato istituito il Piano Transizione 5.0 che riconosce un credito d’imposta a favore delle imprese impegnate nel processo di transizione digitale ed energetica.
Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 1/E del 12 gennaio 2026, ha fornito indicazioni ai fini della fruizione del credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025.
Il credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025 è suddiviso in 5 quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili nel cassetto fiscale, accessibili dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
L’importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il codice tributo “7072” e, quale anno di riferimento, quello dal quale è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito derivante dalla ripartizione.
In fase di elaborazione dei modelli F25 l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati per verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24.
Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta.
A seguito della suddivisione in 5 quote, il plafond relativo agli anni 2024 e 2025 è ridotto dell’importo ripartito e il credito residuo è pari a zero.
(Vedi risoluzione n.1 del 2026)
|
 |
Chiarimenti sulla cessione a terzi del credito d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate - Art. 44-bi Dl n. 34/2019 - parziale rettifica risoluzione n. 32/E/2025
L’articolo 44-bis del decreto legge n. 34/2019 convertito, con modificazioni, nella legge n. 58/2019 dispone la disciplina agevolativa riguardante la trasformazione in crediti d'imposta delle “attività per imposte anticipate” (Deferred Tax Assets - DTA).
Il documento fornisce chiarimenti in merito all’eventualità in cui il credito d’imposta sia ceduto a terzi. Ricordiamo che gli stessi crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione o chiesti a rimborso. La cessione dei crediti d’imposta a terzi è disciplinata dagli articoli 43-bis e 43-ter del Dpr n. 602/1973.
Nei confronti dei soggetti che non appartengono allo stesso gruppo, i predetti crediti possono essere ceduti solo se previamente chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi, secondo le modalità previste dall’articolo 43-bis.
La cessione dei crediti d’imposta ex articolo 43-bis:
- deve risultare ‘da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio’;
- il relativo atto deve essere notificato alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del cedente.
Il cessionario non può cedere ulteriormente il credito acquistato e non può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, in quanto l’acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude non solo la possibilità di ulteriore cessione ma anche quella di utilizzo in compensazione e consente esclusivamente la monetizzazione del credito acquistato, mediante incasso delle somme oggetto di rimborso. Su tale aspetto l’Amministrazione finanziaria modifica quanto espresso con la risoluzione n. 32/E/2025. Sono salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di pubblicazione della presente risoluzione.
(Vedi risoluzione n. 73 del 2025)
|
 |
Novità in tema di tracciabilità delle spese per le trasferte o le missioni e delle spese di rappresentanza, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente autonomo e d’impresa
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, fornisce le istruzioni sulle novità introdotte dal decreto delegato Irpef e dalla legge di Bilancio 2025 in merito alla disciplina delle trasferte e delle missioni dei lavoratori dipendenti.
Il decreto delegato Irpef ha disposto che i rimborsi delle spese di viaggio e di trasporto per le trasferte, nell’ambito del territorio comunale, non concorrono a formare il reddito, se le stesse sono documentate e comprovate.
La manovra 2025 ha inoltre previsto che le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea sono deducibili dal reddito d’impresa e i relativi rimborsi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, solo se effettuate con mezzi di pagamento tracciabile. La stessa limitazione della deducibilità è prevista per le spese di rappresentanza.
Il documento di prassi amministrativa illustra, inoltre, le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, introdotte dal decreto legge fiscale convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 30 luglio 2025 che ha circoscritto, in relazione alla determinazione dei redditi di lavoro dipendente o d’impresa, l’obbligo della tracciabilità alle spese sostenute in occasione di trasferte o missioni in Italia.
Il decreto legge fiscale è intervenuto anche sul trattamento delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute nel territorio dello Stato dal lavoratore autonomo e riaddebitate analiticamente al committente, nonché di quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi e delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione di incarichi.
L’intento è quello di realizzare un coordinamento tra le disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti e la nuova disciplina per la determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Al lavoratore dipendente inviato in trasferta, oltre alla retribuzione, è riconosciuto una indennità di trasferta o di missione per la prestazione lavorativa effettuate fuori sede. Allo stesso è riconosciuto anche il rimborso delle spese sostenute in occasione di trasferte e missioni.
Il trattamento fiscale di dette somme è diverso a seconda che l’attività sia svolta fuori dal territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro o sia svolta all’interno dello stesso comune.
Qualora la trasferta avvenga fuori dal territorio comunale la norma prevede tre sistemi, tra loro alternativi, di rimborso delle spese sostenute dal dipendente: forfetario, misto e analitico.
Il sistema forfetario prevede l’erogazione di un’indennità giornaliera al dipendente, determinata in via forfetaria, al netto delle spese di viaggio e trasporto. Gli importi di tale indennità giornaliera non concorrono alla formazione del reddito fino a 46,48 euro per le trasferte in Italia (elevati a 77,47 euro per le trasferte all’estero). In caso di erogazione dell’indennità di trasferta, i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto non concorrono comunque a formare il reddito quando le spese stesse siano rimborsate sulla base di idonea documentazione, mentre restano assoggettati a tassazione tutti i rimborsi di altre tipologie di spesa.
Nel sistema misto è corrisposto, in aggiunta all’indennità di trasferta, anche il rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio. In tal caso, la franchigia di 46,48 euro è ridotta di un terzo in caso di rimborso delle spese di vitto o alloggio, nonché nei casi di vitto o alloggio fornito gratuitamente, e di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio sia di quelle di vitto, o in caso di vitto e alloggio forniti gratuitamente. Quando sono effettuati sulla base di idonea documentazione i rimborsi analitici delle spese di viaggio e di trasporto non concorrono a formare il reddito.
Non concorrono al reddito di lavoro dipendente le spese rimborsate al lavoratore di vitto e alloggio, viaggio e trasporto. Escluso da imposizione anche il rimborso di altre spese, come lavanderia, telefono e mance, se attestate analiticamente dal dipendente in trasferta, fino a un importo giornaliero di 15,49 euro.
A seguito delle modifiche contenute nel decreto delegato Irpef ‘le indennità o rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito’. Ne consegue che, anche in caso di trasferta nell’ambito del territorio comunale, non concorre a formare il reddito il rimborso, sotto forma di indennità chilometrica, riconosciuto al lavoratore per l’utilizzo del mezzo privato, purché comprovato e documentato.
Anche i rimborsi delle spese di parcheggio non concorrono alla formazione del reddito purché comprovate da documenti giustificativi che indichino il veicolo e la sosta.
L’Agenzia delle Entrate si sofferma poi sulle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2025 in merito ai rimborsi delle spese, sostenute durante le trasferte e le missioni, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, come taxi e servizio di noleggio con conducente (NCC). Questi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente qualora i pagamenti delle predette spese siano eseguiti con mezzi tracciabili.
La condizione di tracciabilità interessa sia le trasferte o missioni all’interno del comune, sia quelle effettuate fuori dal territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro.
Dallo scorso 1°gennaio, pertanto, i rimborsi di tali spese non concorrono al reddito di lavoro dipendente solo se sostenute con metodi di pagamento tracciabile. Restano esonerate dalla tracciabilità le spese ulteriori, diverse da quelle previste dalla nuova disposizione, fino all’importo massimo di 15,49 euro. Anche le spese per trasferte all’estero non concorrono alla formazione del reddito purché documentate con mezzi tracciabili.
Con l’entrata in vigore dell’art. 54, comma 2-bis del Tuir, a partire dal 1°gennaio 2025, se le spese sostenute dal lavoratore autonomo, nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, non siano state pagate con strumenti di pagamento tracciabili, i rimborsi ad esse relativi concorrono a formare il reddito del medesimo. Tale disposizione si applica alle spese sostenute a partire dal 1°gennaio 2025.
Il decreto fiscale ha disposto che sono deducibili le spese sostenute nel territorio dello Stato, nell’esercizio dell’arte o professione, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, comprese quelle sostenute direttamente quale committenti di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché dei rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte o missioni dei dipendenti ovvero corrisposti ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione di incarichi, a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale o con altro sistema di pagamento tracciabile.
Le spese di rappresentanza sostenute nei limiti dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta sono deducibili, a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale o con altri mezzi di pagamento tracciabile.
L’articolo 95 del Tuir dedicato alla deducibilità dal reddito d’impresa delle spese per le trasferte sostenute dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori è stato modificato dalla riforma con l’introduzione del comma 3-bis che subordina all’utilizzo di metodi di pagamento tracciabile la deducibilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e NCC. L’obbligo si applica a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 ma non si applica ai rimborsi erogati per spese sostenute nel periodo d’imposta precedente.
Da ultimo il decreto fiscale è intervenuto anche in materia limitando la condizione alle spese sostenute nel territorio dello Stato e eliminando il riferimento alle spese sostenute per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, per le quali la nuova disciplina è articolata nel nuovo comma 5-ter dell’articolo 109 del Tuir.
Ne consegue che l’articolo 109 in parola si applica alle spese sostenute, ad esempio, dagli amministratori di società, non titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati, mentre si applicherà l’articolo 95, comma 3-bis, del Tuir qualora l’amministratore di società sia titolare di rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa presso la società per cui opera.
Se le spese sono sostenute per le prestazioni di servizi commissionate, ad esempio, ai lavoratori autonomi occasionali, trova applicazione l’articolo 109, comma 5-bis.
La circolare, infine, si sofferma sull’articolo 108, comma 2, del Tuir, in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza il quale dispone che il regime di tracciabilità si estende anche alle spese di rappresentanza. L’obbligo di sostenere la spesa mediante mezzi di pagamento tracciabile non si applica alle spese di pubblicità e di sponsorizzazione, in quanto tali spese non rientrano nella categoria delle spese di rappresentanza.
<<
Le modifiche in tema di spese di rappresentanza si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
La legge di Bilancio 2025 estende l’applicazione delle novità normative in tema di tracciabilità delle spese di rappresentanza alla determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap.
(Vedi circolare n. 15 del 2025)
|
 |
Il nuovo regime transfrontaliero di franchigia in materia di imposta sul valore aggiunto
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E del 16 dicembre 2025, ha esaminato le novità introdotte dal decreto legislativo 13 novembre 2024 n. 180 in merito al regime frontaliero di franchigia in materia di imposta sul valore aggiunto.
Il decreto in parola consente a coloro che sono stabiliti all’interno della Ue di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi in altri Paesi membri senza applicazione dell’Iva e senza diritto alla detrazione. Previsti, inoltre, adempimenti amministrativi semplificati.
Il nuovo regime transfrontaliero può essere adottato dai soggetti che risultano stabiliti in un determinato Stato membro dell’Unione europea, risultando irrilevanti eventuali identificazioni in altri Stati membri diversi da quello di stabilimento. Non possono, invece, aderire al regime di franchigia transfrontaliero i soggetti stabiliti al di fuori della Ue, anche qualora tali soggetti operino attraverso stabili organizzazioni esistenti in uno o più Paesi membri.
Il soggetto passivo che ha esercitato l’opzione per l’applicazione del regime di franchigia deve applicare tale regime in relazione a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in quello Stato. Non è possibile applicare nel medesimo Stato il regime di franchigia per alcune operazioni attive, assoggettandone altre al regime ordinario; il contribuente può, invece, scegliere di operare in regime di franchigia in alcuni Stati membri e di identificarsi in altri per effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi, applicando le regole ordinarie.
Il soggetto passivo che intende applicare il regime di franchigia in altri Stati deve chiedere l’autorizzazione al proprio Stato di stabilimento attraverso un’apposita procedura che prevede l’interlocuzione dello Stato di stabilimento con gli Stati di esenzione al fine di verificare che il soggetto sia in possesso dei requisiti per aderire al regime stesso.
Dalla norma emerge che i soggetti passivi che aderiscono al regime di franchigia transfrontaliero:
- non esercitano la rivalsa dell’Iva, con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio della Ue;
- non hanno diritto alla detrazione dell’imposta relativa ad acquisti di beni e servizi afferenti alle operazioni attive in franchigia;
- devono rispettare il requisito di un volume d’affari annuo non superiore alle due diverse soglie di 100.000 euro e di 85.000 euro. In primo luogo deve essere rispettata la soglia massima di 100.000 euro di volume d’affari complessivo nella Ue. In secondo luogo devono essere rispettate le specifiche soglie di volume d’affari fissate da ciascuno Stato membro di esenzione per le operazioni ivi effettuate.
Il regime in parola è riservato ai soggetti stabiliti nell’Unione europea. Nell’ambito di tale regime l’Italia può rivestire un ruolo di:
- Stato di stabilimento;
- Stato di esenzione.
L’art. 70-terdecies del decreto Iva al comma 2 stabilisce che il regime di franchigia transfrontaliero non si applica:
- alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti in un altro Paese membro;
- alle cessioni di beni e prestazioni di servizi escluse dallo Stato di esenzione.
Ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime di franchigia risulta fondamentale la determinazione del volume d’affari annuo complessivo nell’Unione europea (massimo 100.000 euro) e del volume d’affari annuo realizzato in ciascun Paese membro.
Alla determinazione del volume d’affari imputabile a ciascun Stato membro concorrono tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo, territorialmente rilevanti in ogni Stato. In Italia, ad esempio, rilevano: le cessioni nazionali di beni e servizi rese nel territorio dello Stato; le esportazioni di beni dall’Italia verso un Paese terzo; le cessioni intra-Ue di beni trasportati o spediti dall’Italia in un altro Paese membro.
Concorrono, inoltre, alla formazione del volume d’affari in Italia le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti dall’Italia in un altro Stato membro a soggetti privati, qualora l’ammontare complessivo delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nella Ue non abbia superato 10.000 euro e il cedente non abbia optato per l’imposizione nello Stato di destinazione.
Alla determinazione della soglia non concorrono:
- le cessioni di beni d’investimento materiali o immateriali;
- le operazioni esenti.
I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato possono accedere al regime di franchigia transfrontaliero a patto che:
- siano rispettati gli adempimenti procedurali: il soggetto passivo deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate una ‘comunicazione preventiva’ di ammissione al regime con cui si chiede l’attribuzione del codice identificativo EX;
- siano verificati i requisiti stabiliti dallo Stato membro di esenzione: il soggetto passivo non deve aver superato la soglia annua di volume d’affari stabilita ai fini dell’applicazione del regime;
- sia rispettato il requisito unionale: il soggetto passivo deve aver realizzato all’interno dell’Unione europea un volume d’affari complessivo annuo non superiore a 100 mila euro.
Non possono invece accedere al regime in parola le stabili organizzazioni in Italia di soggetti stabiliti in altri Stati membri, nonché i soggetti passivi non stabiliti in Italia che siano identificati ai fini dell’Iva. Precluso l’accesso anche a stabili organizzazioni in Italia di soggetti stabiliti fuori dell’Unione europea.
I soggetti passivi stabiliti in Italia che intendono accedere al regime transfrontaliero devono inoltrare, mediante procedura web, una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, chiamata a valutare l’istanza. Il decreto Iva all’articolo 70-terdecies elenca dati e informazioni che il soggetto richiedente è tenuto a indicare nella comunicazione preventiva. Si tratta di una comunicazione, per ogni trimestre dell’anno civile, nella quale va comunicato l’ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in Italia e in ognuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati membri diversi da quelli di esenzione.
L’inosservanza del termine di presentazione della comunicazione è punibile con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
Entro tre anni dalla scadenza relativa al trimestre civile di riferimento, è consentito presentare una comunicazione trimestrale ‘correttiva’ di quella in precedenza trasmessa, esclusivamente nei seguenti casi:
- correzione di errori od omissioni della comunicazione originaria;
- venir meno, in tutto in parte, di alcune delle operazioni effettuate in tale trimestre civile.
La comunicazione che sostituisce la precedente deve riportare, oltre al dato modificato, anche tutte le altre informazioni già in precedenza trasmesse. Se sono presentate più comunicazioni riferite al medesimo trimestre civile, l’ultima sostituisce le precedenti.
I soggetti stabiliti in altri Stati membri della Ue applicano il regime di franchigia in Italia alle stesse condizioni dei soggetti stabiliti in Italia per l’adesione al regime forfetario. Solo le persone fisiche soggetti passivi d’imposta sono ammesse al regime transfrontaliero in Italia. L’accesso richiede il rispetto del volume d’affari annuo di 85.000 euro o della soglia inferiore prevista dalla legge di Stabilità 2015. Per i soggetti già identificati in Italia, il numero di partita Iva italiano viene cessato per quanto concerne le operazioni attive effettuate in Italia in regime di franchigia. Ciò non vale per gli adempimenti degli obblighi derivanti da operazioni per cui il soggetto stesso sia debitore d’imposta.
La cessazione del regime di franchigia può essere ‘volontaria’ o ‘obbligatoria’, ciascuno con effetti e decorrenze diverse.
Con un aggiornamento della comunicazione preventiva il soggetto passivo Iva stabilito in Italia informa l’Agenzia delle Entrate che non intende più avvalersi del regime in uno o più Stati membri di esenzione. Se il soggetto passivo continua ad avvalersi del regime di franchigia transfrontaliero in altri Stati membri, diversi da quelli per i quali ha comunicato la volontà di fuoriuscire dal regime, lo stesso deve continuare a inviare le comunicazioni trimestrali nello Stato o negli Stati membri nei quali non si avvale più del regime.
La cessazione obbligatoria dal regime di franchigia transfrontaliero si verifica qualora il soggetto passivo stabilito in Italia abbia superato la soglia nazionale di volume d’affari annuo prevista da tale Stato per l’applicazione della franchigia, oppure quando lo Stato di esenzione abbia comunicato che nel suo territorio sono venute meno le condizioni per l’applicazione del regime di franchigia.
(Vedi circolare n. 13 del 2025)
|
 |
Rinnovazione di ipoteca - Predisposizione della nota per l’esecuzione della formalità nei registri immobiliari in caso di intervenute modifiche nei soggetti o nei beni
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 69/E del 17 dicembre 2025, è intervenuta sulle formalità di rinnovazione delle ipoteche nei registri immobiliari e ha fornito indicazioni sulla corretta modalità di redazione delle note di iscrizione in rinnovazione delle ipoteche, rispetto alla situazione esistente al momento dell’iscrizione originaria, soprattutto quando siano intervenute modifiche nel lato soggettivo o oggettivo.
Incertezze hanno riguardato anche le modalità di pagamento dei tributi dovuti per il rilascio di copie della originaria nota di iscrizione da presentare, in luogo del titolo, per la richiesta della formalità di rinnovazione.
L’attuale contesto, caratterizzato da una durata dei mutui spesso elevata ben oltre i venti anni, ha reso sempre più frequente la necessità di rinnovare le iscrizioni ipotecarie nei registri immobiliari. La rinnovazione, disciplinata dall’articolo 2850 c.c., produce una proroga degli effetti dell’ipoteca originariamente iscritta. Proprio in merito alla rinnovazione delle ipoteche nei registri immobiliari sono emerse alcune difformità di comportamento delle conservatorie. L’auspicio è quello che si arrivi ad adottare una procedura ‘standardizzata’ che garantisca maggiore uniformità degli uffici.
La corretta modalità di redazione delle note di iscrizione in rinnovazione è il punto centrale soprattutto quando, rispetto all’iscrizione originaria, siano intervenute modifiche soggettive, come il subentro di nuovi soggetti, per atto inter vivos o mortis causa oppure modificazioni soggettive nel lato creditorio. A rilevare anche i mutamenti che concernono gli immobili dell’ipoteca soggetta a rinnovazione, come le modifiche nella identificazione catastale dei beni ipotecati o la liberazione parziale dei beni dal gravame della garanzia.
La nota di iscrizione in rinnovazione va redatta scrupolosamente affinché rifletta la nuova realtà ed eviti disallineamenti che potrebbero condizionare negativamente le esigenze di una chiara e compiuta pubblicità.
Le modalità di pagamento dei tributi per il rilascio di copie rappresentano un altro motivo di frizione. La legge consente che la copia della nota originaria di iscrizione sostituisca il titolo nella richiesta di rinnovazione, ma le procedure di rilascio non sempre sono chiare e uniformi come pure le opzioni di pagamento.
Proprio per questo motivo l’Agenzia delle Entrate ha voluto fornire indicazioni precise agli operatori e promuovere buone pratiche per uniformare le prassi operative.
In particolare, per le modifiche dei titolari degli immobili ipotecati, la nota di iscrizione in rinnovazione dovrà riportare sia i soggetti originari sia quelli eventualmente subentrati. Nel caso di modifiche intervenute dal lato soggettivo creditorio, la rinnovazione potrà validamente eseguirsi con l’indicazione dell’originario creditore, ma, per una pubblicità più aderente alla realtà, potrà eseguirsi anche nei confronti del nuovo creditore; analogamente potrà operarsi nel caso di sopravvenute modifiche relative agli immobili ipotecati.
Da ultimo, la risoluzione fornisce chiarimenti sulle modalità di pagamento dei tributi per il rilascio di copia da presentare in luogo del titolo per ottenere la rinnovazione. A far data dal 1°luglio 2017 è utilizzabile il modello ‘F24 Versamenti con elementi identificativi’ (F24 elide) per il pagamento di imposte e tasse per i servizi ipotecari e catastali ma anche per il rilascio di certificati, copie e attestazioni.
(Vedi risoluzione n. 69 del 2025)
|
 |
Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 36-bis Dpr 600/1973 o dell’art. 54-bis Dpr 633/1972
Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 36-bis del Dpr n. 600/1973 o dell’art. 54-bis del Dpr n. 633/1973, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 70/E del 18 dicembre 2025, ha istituito una serie di codici tributi.
I nuovi codici tributo sono utilizzabili nei casi in cui il contribuente, destinatario delle predette comunicazioni, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.
In tal caso è necessario predisporre un modello F24 nel quale i codici tributo sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento reperibili all’interno delle citate comunicazioni.
(Vedi risoluzione n. 70 del 2025)
|
 |
Codici tributo per il versamento del Prelievo erariale unico di cui all’art. 39 Dl n. 269/2003 - Compilazione campo ‘codice identificativo’
Nel 2007 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il modello ‘F24 Accise’, del Prelievo erariale unico di cui all’articolo 39, commi 13 e 13-bis del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 71/E del 18 dicembre 2025, chiarisce come va compilato il campo ‘codice identificativo’ nel modello ‘F24 Accise’ quando i concessionari effettuano i versamenti relativi al Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento.
La direzione Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha richiesto ai concessionari, per i codici tributo interessati, la compilazione del campo ‘codice identificativo’ nella sezione ‘Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione’ del modello ‘F24 Accise’.
I codici tributo interessati sono compresi nella forchetta che inizia dal ‘5155’ e termina al 5172’.
(Vedi risoluzione n. 71 del 2025)
|
 |
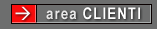 |
| copyright Studio Orlandini e Associati | partita iva: 02255380160| site by metaping |
|
|
|
